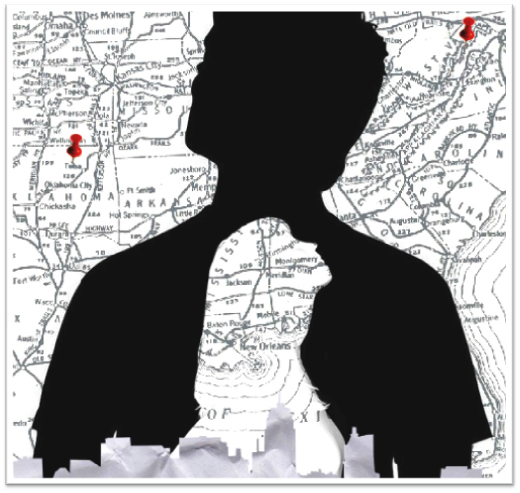In questo articolo vi racconto come John Green, attraverso il libro Città di Carta, abbia creato una mappa per scardinare un’idea di realtà che potesse farne emergere un’altra più vera. La mappa è nascosta nel testo, è tutto scritto, nero su bianco, basta seguire gli indizi disseminati in tutto il romanzo.
John Green ha da tempo scelto un suo territorio di intervento, con personaggi strani e situazioni terribili, sempre con lo scopo non di intrattenere ma di allargare la conoscenza mettendo ordine al caos: quello del proprio mondo e quello del mondo esteriore. I suoi personaggi (e i suoi lettori) sono impegnati ad appropriarsi della propria vita e a disegnare i confini della propria identità.
La letteratura è così uno strumento conoscitivo di se stessi e del mondo, attento alla complessità della realtà e alle possibilità di immaginarsi in modi nuovi e possibili. In quest’ottica, se Le Città invisibili di Calvino rappresentano il tentativo esemplare di “cercare e sapere riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare e dargli spazio”, il tentativo quindi di uscire dal labirinto e immaginare un nuovo modo di abitare, Città di Carta di John Green rappresenta il tentativo di uscire dal labirinto delle convinzioni, dei preconcetti, e in particolare, delle invenzioni cinematografiche e letterarie. Nello specifico, in questo romanzo, John Green, completando un processo già iniziato in Cercando Alaska, cerca di demolire lo stereotipo della Manic Pixie Dream Girl (MPDG), figura femminile poco profonda ed eccentrica, inventata da registi e sceneggiatori, per illuminare la strada di giovani uomini “qualunque”, per aiutarli a vivere in modo più intenso e avventuroso. Questa definizione è stata usata per la prima volta dalla critica cinematografica Nathan Robin, in un recensione redatta all’indomani dell’uscita del film Elizabethtown. La pellicola, che celebra la vita e la rinascita, sacrifica la figura di una bizzarra ed estroversa hostess di volo, per aiutare un affermato giovane designer di scarpe in crisi. Un’invenzione, questa della Manic Pixie Dream Girl, difficile da smantellare, così come per la maggior parte degli stereotipi e pregiudizi che brulicano nelle nostre mappe mentali.
Attraverso l’originale struttura del romanzo, Green dà la possibilità a Quentin Jacobsen, il protagonista maschile, perdutamente ossessionato da Margo Roth Spielgman, la nostra Manic Pixie Dream Girl, di conoscerla meglio e di cambiare idea su di lei. E di conseguenza offre al lettore, che si identifica con il protagonista maschile, la possibilità di comprendere meglio sia la personalità di Margo sia di capire quali effetti deleteri producano i pregiudizi e le idee superficiali che ci facciamo degli altri. Ecco la mappa a cui accennavo nell’incipit.
Se conveniamo con il professor Thomas C. Foster che ogni storia contiene al suo interno una ricerca, anche Città di Carta conterrà una missione da compiere[1]. La missione, innanzitutto, prevede un cercatore, che nel romanzo è palesemente Quentin, dal momento che tutta la storia è raccontata dalla sua prospettiva, e che non casualmente è soprannominato dagli amici Q, lettera con la quale inizia la parola Quester, colui che fa domande in continuazione, a sé stesso e agli altri, preoccupato com’è dalle sorti di Margo. Ogni ricerca ha poi bisogno di un posto dove andare, e nel corso del romanzo Quentin si reca in molti luoghi, da un centro commerciale abbandonato, agli pseudo quartieri alla periferia di Orlando, fino ad Agloe, la città di carta per eccellenza. Agloe, come specifica l’autore in una nota alla fine del testo, è una città inventata dai cartografi della Esso per tutelare il proprio lavoro e firmare così le proprie mappe: chi le avesse copiate senza togliere Agloe, si sarebbe macchiato di plagio. Per uno scherzo del destino, la città è divenuta reale perché qualcuno, basandosi proprio sulle mappe della Esso, insistette per cercarla e costruirvi un negozio. Un esercizio commerciale che al momento risulta chiuso ma che può risorgere dalle ceneri in qualsiasi momento, se qualcuno decidesse di ridargli vita. Proprio come accade alle idee.
Il terzo elemento che connota ogni ricerca è che il cercatore deve avere un motivo esplicito per compiere questa azione, che in questo caso consiste nel ritrovare Margo. La ragazza, infatti, dopo una notte rocambolesca vissuta insieme a Quentin, con l’obiettivo di vendicarsi del ragazzo e delle amiche che ritiene la abbiano tradita, fugge lasciando dietro di sé una serie di indizi da decifrare per la famiglia e la polizia alla sua ricerca.
[pullquote align=center]Conoscevo il suo profumo e sapevo come si comportava con me e come si comportava con gli altri, sapevo che le piacevano la Mountain Dew, le avventure e i gesti teatrali, e sapevo che era divertente e brillante e che in generale era più avanti di noi altri. Ma non sapevo che cosa l’avesse portata lì, che cosa l’avesse trattenuta e che cosa l’avesse fatta andare via. Non sapevo perché aveva migliaia di dischi ma non aveva mai rivelato a nessuno la sua passione per la musica. Non sapevo che cosa faceva di notte, con la tenda abbassata, la porta chiusa, nella privacy impenetrabile della sua stanza. E forse era questo che dovevo fare più di ogni altra cosa: scoprire chi era Margo quando non era Margo.
[/pullquote]
Il fatto stesso che Margo fuggendo lasci tanti indizi è sintomatico del fatto che voglia essere ritrovata. Questo elemento dovrebbe metterci in guardia sulla sua figura contraddittoria. Margo è veramente una MPDG, un mito, oppure è una persona in carne e ossa? Funzionale al romanzo, come per Quentin, la scelta del nome della ragazza: Margo Roth Spielgman.
Margo contiene al suo interno la parola Go, che già di per sé è un invito ad andare verso di lei. Spielgman rimanda invece al vocabolo tedesco che significa specchio. In effetti, nell’economia del romanzo, Margo funziona proprio come uno specchio, un buono specchio, proprio come quello di cui parla il padre di Quentin una sera a tavola, mentre la famiglia è intenta a riflettere su come e quanto fosse difficile per un ragazzo vedere i propri coetanei semplicemente come persone.
[pullquote align=center]
«Più faccio il mio lavoro, più mi rendo conto che gli esseri umani sono sprovvisti di buoni specchi. È durissima per gli altri spiegare a noi come ci vedono è durissima spiegare agli altri come ci sentiamo.» Dice il padre.
«Difficile considerare gli altri come esseri umani al pari di noi» aggiunge la madre finendo con il dire che è più facile tendere a «idealizzarli o a bollarli come animali.»
Tornando al nome, Roth in tedesco significa Rosso: un colore che spicca, un segnale di allerta che si contrappone agli altri, in particolare alla maggior parte delle figure simboliche disseminate nel romanzo che sono in prevalenza di colore bianco o nere. Là dove il bianco rappresenta cose e ambienti vuote di significato (la carta, le pareti del muro della scuola, la mucca contro cui si scontra il mini caravan di Quentin durante il viaggio da Orlando a New York), il nero sembra rappresentare la volontà di dare nuovi significati alle cose. Ci basti pensare ai Babbo Natale di colore, che i genitori di Radar, un caro amico di colore di Quentin, collezionano ossessivamente proprio per smantellare il luogo comune che lascia immaginare Santa Klaus di origine caucasica. Nero su bianco come la scrittura che Green usa per smantellare un’idea. Anche i soprannomi degli amici di Quentin sono tutti significativi e tratteggiano le peculiarità dei loro caratteri. Radar, per tutta la storia si comporta come un Radar. È lui che individua gli aggiornamenti su internet di Margo e capta ogni nuova notizia su Omnictionary, una sorta di Wikipedia.
Un altro elemento fondamentale di questa ricerca è che il cercatore deve superare una serie di sfide e di prove. Tutto il viaggio che Quentin compie è in realtà un percorso a ostacoli che provoca arresti e rallentamenti, ma che non riesce mai a fermarlo, fino alla fine. Soltanto trovare e decifrare gli indizi che Margo lascia dietro di sé costituisce un problema, per non parlare poi degli scontri che Q deve affrontare con gli amici e con la sua famiglia o l’esperienza vicino alla morte causata dal frontale con la mucca, durante il viaggio che Quentin compie verso Agloe, la città dove si è nascosta Margo.
Il romanzo è diviso, in modo non convenzionale, in tre parti più il prologo (I Fili, L’Erba, La Nave) ognuna delle quali contiene una metafora che ha la funzione di far comprendere meglio la figura complessa e molteplice di Margo, in modo da riconsiderare le fantasie fatte su di lei e iniziare a vederla nella sua interezza. Non a caso l’edizione francese di Città di Carta che non mantiene il titolo originale (Paper Town), porta il titolo di Le face cachée de Margo.
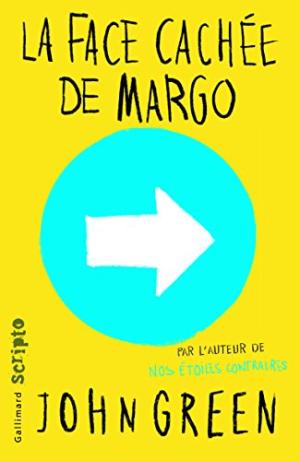
Copertina dell’edizione francese di Città di Carta
Per tutto il tempo – non solo da quando era scomparsa, ma da dieci anni almeno – avevo pensato a lei senza ascoltare, senza sapere che l’avevo ridotta a una misera finestra. E non ero riuscito a pensare a lei come a una persona che poteva avere paura, che forse si sentiva sola in mezzo a tanta gente, che magari si vergognava di condividere la sua collezione di dischi perché era una cosa troppo personale. Una persona che divorava guide di viaggio perché voleva fuggire da una città in cui molti si rifugiavano. Una persona che non aveva nessuno con cui parlare perché nessuno l’aveva mai vista come una persona.
Margo non è una idea ma una persona. Ci vorrà, però, un intero romanzo per trasformare colei che viene considerata “un’avventura”, “una cosa incantevole e preziosa”, in una persona dall’identità complessa. Infatti Quentin non ha mai conosciuto Margo veramente. Gli unici ricordi che ha di lei riguardano i tempi dell’infanzia: “Lei era in assoluto l’essere più fantasticamente meraviglioso che Dio avesse creato…” A soli nove anni Margo appare diversa e più disinvolta della maggior parte dei bambini della sua età. Di fronte al cadavere di uno sconosciuto, suicidatosi nel parco a causa della depressione per l’imminente divorzio dalla moglie, Margo, al contrario di Quentin, fa due passi avanti.
Mentre indietreggiavo, Margo fece due identici passi in avanti, piccoli e lenti. «Ha gli occhi aperti» disse. «Dobbiamotornareacasa» dissi io. «Pensavo che i morti tenessero gli occhi chiusi» continuò Margo. «Margodobbiamotornareacasaadirlo.» Lei fece un altro passo avanti. Era abbastanza vicina da potergli toccare un piede. «Secondo te che cosa gli è successo?»
Margo vuole sapere, vuole conoscere e per questo conduce un’indagine che la porta a scoprire l’identità dell’uomo. Non un cadavere qualsiasi ma una persona. Robert Joyner viveva nel loro stesso quartiere, in Jefferson Road, e forse si era suicidato perché “tutti i fili dentro di lui si sono rotti”, ipotizza Margo. Con il proseguire della storia Margo appare sempre più idealizzata, lei è la ragazza più cool della scuola, amata e venerata da tutti. Solo dopo la fuga, Quentin inizia a conoscerla veramente, occupando fisicamente e spiritualmente gli spazi vissuti da lei. Là dove per spazi intendo quei luoghi eterotopici à la Foucault, fisici e metaforici, divergenti rispetto ai luoghi della socialità e delle relazioni educative. Si pensi al centro commerciale abbandonato dove Margo stabilisce il suo quartier generale prima della fuga, e dove Quentin torna più volte a cercare indizi. Oppure a quegli pseudo quartieri che Quentin percorre in lungo e largo per cercarla, credendola morta. Spazi urbani lasciati all’incuria che rappresentano spazi non semantizzati, fogli bianchi su cui è ancora possibile lasciare il proprio segno.
Per conoscere meglio Margo, per sentire come si sente non basta vederla da lontano o attraverso i racconti che circolano sul suo conto. “Tutte le cose sono più brutte da vicino” suggerisce Margo a Quentin in cima al Sun Trust Building, l’edificio più alto di Orlando, mentre osservano la città dal venticinquesimo piano, la notte prima della fuga. “Ecco il brutto: da quassù non vedi la ruggine, la vernice scrostata, ma capisci che razza di posto è davvero. Vedi quanto è falso. Non è nemmeno di plastica, persino la plastica è più consistente. È una città di carta.” Una città priva di consistenza, senza profondità, una città per una ragazza che si sente di carta perché non è altro che l’idea che gli altri si sono fatti di lei. Margo è una ragazza di carta, o almeno è così che gli altri la fanno sentire, e per acquistare profondità non gli resta che recarsi ad Agloe dove tutto può essere ricreato. La ragazza ideale Margo esiste solo nella testa di chi la immagina.
La verità è che tutte le volte che sono salita in cima al SunTrust Building – compresa quella volta con te – e ho guardato giù, non ho pensato che quello che vedevo fosse di carta. Guardavo giù e pensavo che quella fatta di carta ero io. Ero io la persona leggera e facile da piegare, non gli altri. E qui sta il problema. Alle persone piace l’idea di una ragazza di carta. È sempre stato così. E la cosa peggiore è che anche a me piaceva quell’idea. L’ho coltivata, capisci cosa intendo? «Perché è fantastico incarnare un’idea che piace a tutti, però non potevo essere quell’idea anche per me stessa, non sempre. E Agloe è un posto in cui un’invenzione di carta è diventata realtà. Un punto su una mappa è diventato un posto reale, più reale di quanto i disegnatori stessi della mappa abbiano potuto immaginare. Così ho pensato che anche la sagoma di carta di una ragazza potesse diventare una persona vera qui. Era come se stessi dicendo a quella ragazza di carta tutta presa dall’ansia di piacere e dai vestiti: “Stai andando nella città di carta. E non tornerai più indietro”
La fuga mette distanza tra lei e Quentin, colui che più di tutti è ossessionato dal suo mito, e quella lontananza le dà la possibilità di continuare a esistere, almeno fino a quando non viene riconosciuta per quello che è. Una ragazza vera che vive e soffre come tutti gli altri, una ragazza che può desiderare mettere fine alla sua vita, se non fosse che quello che in realtà vuole uccidere non è “nella sottile vena azzurra” ma in un luogo “più profondo, più segreto, e molto più difficile da raggiungere.“
È l’idea che deve essere annientata. Un’invenzione da distruggere. Ognuno di noi è legato all’altro, perché ognuno di noi può immaginare e capire l’altro.
Attraverso la metafora dei “Fili”, le corde che si possono spezzare, Green fa intravedere Margo come una persona che può soffrire, e che è proprio come ogni adolescente che sperimenta il dolore, anche se non sempre si vede perché non è facile comunicarlo agli altri.
Per mezzo della metafora dell’ “Erba” veicolata dai versi di Walt Whitman, contenuti in Canto di me stesso, ci lascia immaginare Margo come una persona ancora più profonda, impossibile da conoscere completamente.
L’erba mi ha portato a te, mi ha aiutato a immaginarti come una persona vera. Noi però non siamo germogli diversi nati da una stessa pianta. Io non posso essere te. Tu non puoi essere me. Puoi arrivare a immaginare abbastanza bene una persona, però mai a vederla alla perfezione.
Una persona vera che si può rompere irrimediabilmente. A meno che non ci si guardi davvero, attraverso quelle crepe e fessure che di tanto in tanto si aprono e lasciano intravedere la realtà invece delle idee. Come spiega efficacemente attraverso la metafora della “Nave”: le crepe nello scafo, se non vengono riparate, prima o poi ti fanno affondare.
Nel momento in cui Quentin abbandona la falsa percezione che ha di Margo, Green finisce di demolire lo stereotipo della MPDG, per farci finalmente vedere la persona reale, non il personaggio idealizzato. E nel finale, non proprio convenzionale per il genere in questione che prevede quasi sempre un lieto fine, scegliendo di dividere le strade di Margo e Quentin, che per un breve tratto dell’esistenza si sono incontrate, l’autore dà la possibilità al personaggio maschile di iniziare da solo una nuova vita e, contemporaneamente, al lettore offre la possibilità di immaginare il futuro, di poterlo far diventare reale. Ma non solo.
Alla fine del romanzo quando ogni mistero è stato risolto, quando ogni personaggio si trova nel posto giusto, quando la mappa è stata srotolata completamente, e il processo che ci ha portato a sentire profondamente Margo è stato compiuto, non rimane che provarci di nuovo, scoprire altre mappe o inventarne di nuove. E far sì che questo processo sperimentato possa ripetersi, se non automaticamente, con più facilità, ed essere condiviso.
Canto me stesso, e celebro me stesso,
E ciò che assumo voi dovete assumere
Perché ogni atomo che mi appartiene appartiene anche a voi.
[…]
Fermati con me oggi e questa notte, e ti impadronirai dell’origine di tutti i poemi,
Ti impadronirai dei beni della terra e del sole (ci sono ancora milioni di soli),
Non prenderai più le cose di seconda o terza mano, né guarderai con gli occhi dei morti, ne ti nutrirai di fantasmi libreschi,
E neppure vedrai attraverso i miei occhi o prenderai le cose da me,
Ascolterai da ogni parte e le filtrerai da te stesso.
(Walt Whitman, Foglie d’erba, traduzione di Enzo Giachino, Einaudi)
Bibliografia
Italo Calvino, Le città invisibili, Mondadori, Milano, 2016
John Green, Città di carta, traduzione di Stefania di Mella, Rizzoli, Milano, 2016.
John Green, Cercando Alaska, traduzione di Lia Celi, Rizzoli, Milano, 2015.
Thomas C. Foster, How to Read Literature Like a Professor: A Lively and Entertaining Guide to Reading Between the Lines, Harper Perennial, 2014.
[1] Thomas C. Foster, How to Read Literature Like a Professor: a Lively and Entertaining Guide to Reading Between the Lines, Harper Perennial, 2014